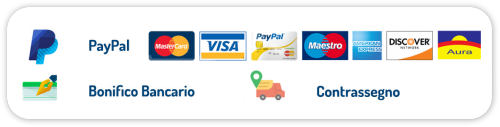Di questo parla l’ultimo Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction (il rapporto annuale dell’ONU che valuta il rischio globale di catastrofi), pubblicato il 17 giugno in occasione dell’ultima giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità e in cui la mancanza di acqua (e accesso all’acqua) vengono definite la peggiore crisi globale latente, la prossima pandemia.
Negli ultimi 20 anni, secondo i dati ONU, ha colpito direttamente almeno 1,5 miliardi di persone, con un costo stimato di 124 miliardi di dollari e si prevede che la maggior parte del mondo vivrà nello stress idrico nei prossimi anni (qui i dati più in dettaglio e qui il rapporto originale, disponibile solo in inglese). Non è difficile immaginarne le conseguenze, se si pensa che la siccità incide in modo determinante sul declino dei raccolti. E tutti dipendiamo dal cibo, anche se in modi diversi a seconda di dove ci troviamo a nascere.
Ma non c’è solo questo, in un mondo globale tutto si tiene e non si può parlare di un problema senza vedere il contesto complesso in cui si inserisce, senza leggerne le dinamiche geopolitiche[1] e le interconnessioni. Quindi partiamo dalla siccità per parlare anche di guerre per le risorse, migranti e cambio climatico, salute del suolo e desertificazione dei nostri territori.
Le conseguenze immediate (e invisibili) della siccità.
UE, FAO e World Food Program ci hanno da poco informato che, nel 2020, almeno 155 milioni di persone sono precipitate nell’insicurezza alimentare acuta a causa di conflitti, shock economici (comprese le conseguenze del COVID-19) ed eventi meteorologici estremi (qui il comunicato). Ovviamente, nel pianeta globale le crisi colpiscono prima i più deboli: basta pensare al dramma dei migranti e dei rifugiati, una questione che dopo essere stata per anni ostaggio di un dibattito politico strumentale e vergognoso, è scivolata con la pandemia nell’indifferenza delle pagine interne dei quotidiani (con qualche eccezione come il Fatto Quotidiano che, nel blog, accoglie spesso voci critiche e temi complessi ignorati dalla narrazione mainsteam).
La questione dell’acqua (e delle risorse)
Questo è un altro aspetto del problema: già alla fine del secolo scorso, con la prima guerra dell’Iraq, era chiaro che le nuove guerre (dichiarate o meno) sarebbero diventate conflitti per le risorse e tra queste, ovviamente, è centrale il controllo dell’acqua, ma il problema è molto più ampio e peggiora continuamente. Se volete approfondire la questione del rapporto geopolitico tra guerra e materie prime potete leggere questi due articoli: il primo, dell’agenzia governativa per la cooperazione internazionale, è dedicato all’impatto delle guerre per l’acqua mentre il secondo, analizza le interconnessioni tra le crisi e in particolare quelle tra estrattivismo (l’appropriazione e lo sfruttamento sistematico di risorse sempre più scarse), la crisi alimentare e il cambiamento climatico.
Ma non è tutto, in Italia l’acqua è stata la base per una mobilitazione e una richiesta di partecipazione e giustizia non diverse da quelle che avevano segnato, nel 2003, l’opposizione alla seconda invasione dell’Iraq. L’acqua come bene comune, come diritto di tutti da difendere e conservare anche per le future generazioni è stata un vero movimento dal basso, con cui molti giovani si sono affacciati alla politica attiva e molti adulti ci sono tornati. Un referendum vinto, il primo di un processo che aveva l’obiettivo di legare politicamente le mani alle multinazionali e al loro sfruttamento metodico del pianeta. Purtroppo, speranze disattese e voci inascoltate, come quelle arcobaleno che in piazza, 10 anni prima, avevano inutilmente chiesto a gran forza la pace e, sempre sul Fatto Quotidiano della scorsa settimana, un interessante articolo ci racconta dove siamo a dieci anni dalla domenica in cui abbiamo festeggiato la vittoria del movimento per l’acqua pubblica.
La desertificazione, anche in casa nostra.
Già tre anni fa, in un’intervista in occasione della giornata mondiale del 2018, Luca Mercalli ci ricordava che l’Italia è a rischio desertificazione: la Pianura Padana potrebbe diventare come il Pakistan e la Sicilia un deserto africano da qui a cento anni, se non si applicano gli impegni dell’Accordo sul clima. “La temperatura globale – spiegava Mercalli – è aumentata di circa un grado nell’ultimo secolo e di 1,5 gradi in Europa occidentale e nel Mediterraneo. L’aumento delle temperature entro la fine del secolo potrebbe arrivare fino a 5 gradi in più”. La buona notizia, ci diceva, è che “possiamo ancora contenerne le conseguenze se agiamo subito” e, curiosamente, concludeva che “non sarà facile come assumere un vaccino, ma è come mettersi a dieta: serve un investimento di responsabilità, costanza e volontà”. Ovviamente non si sta facendo molto e il Covid, sempre lui ☹, ha fatto passare sullo sfondo anche la questione climatica, che sembrava aver finalmente risvegliato l’attenzione pubblica.
Non solo caldo o mancanza d’acqua, ma di vita nel suolo.
Attenzione però, desertificazione non significa solo alla siccità o aumento delle temperature medie ma a un processo più complesso, legato ai metodi agricoli industriali: da decenni ormai per coltivare si libera il territorio da piante, insetti, animali, si irreggimentano i corsi d’acqua, si sfrutta il terreno. Che deve essere continuamente arricchito di sostanze nutritive che ne alterano l’equilibrio, mentre le coltivazioni sono protette da pesticidi e altri inquinanti.
Un ciclo che nel tempo ha mutato irreversibilmente le condizioni del suolo dal punto di vista della fertilità e, oggi, la Pianura Padana è praticamente un deserto in cui, senza intervento dell’uomo, non potrebbe crescere nulla. Su questo tema c’è un rapporto molto dettagliato del IPCC (il panel internazionale che fa da consulente dei governi sul cambiamento climatico) e di cui potete trovare una breve sintesi in italiano, mentre il rapporto completo, in inglese, si scarica qui.
[1] Karl Polanyi, famoso economista ed antropologo, già alla fine degli anni ’50 parlava della difficoltà della “libertà in una società complessa”: faceva riferimento allora, agli Stati Uniti, ma la globalizzazione si è ormai diffusa ovunque e, oggi, siamo tutti parte delle catene lunghe dell’economia mondializzata e, quindi, dell’ingiustizia diffusa che questa determina.